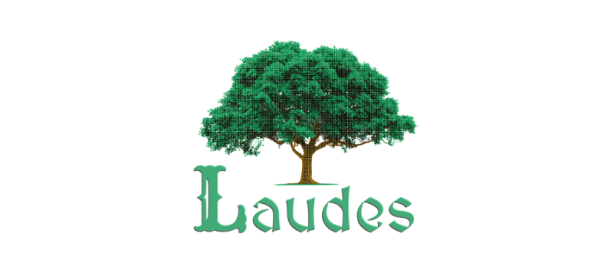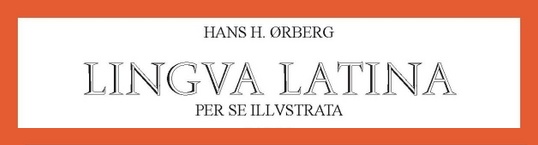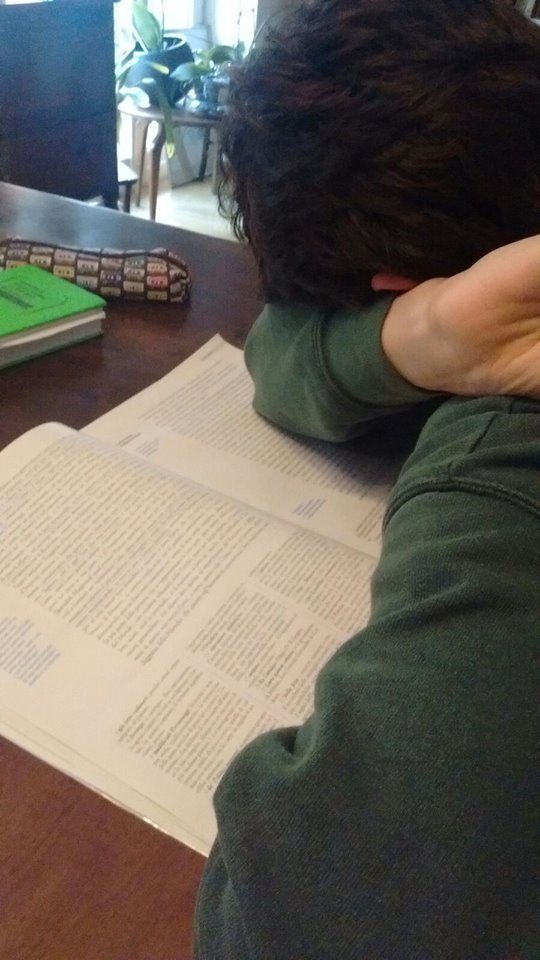Esami di maturità 2017. Per l’analisi del testo della prima prova, la scelta di una poesia di Giorgio Caproni ha suscitato un esteso dibattito (qui un parere positivo e qui uno negativo): al di là delle invettive superficiali, che poco hanno a che fare con la didattica e la verifica di un percorso didattico (“Ma chi lo conosce Caproni?” “È la poesia più brutta di Caproni!”, ecc.), sono emerse delle critiche riguardo ad alcune questioni profonde che un sistema scolastico dovrebbe continuamente affrontare, e su cui ogni persona che lavora in ambito educativo, di ogni livello, dovrebbe riflettere. La domanda che bisognerebbe porsi, direttamente connessa all’esame, è semplicemente questa: cosa stiamo chiedendo agli studenti? Domanda che però ne presuppone un’altra: cosa vogliamo insegnare agli studenti?
Vi proponiamo perciò le opinioni di due nostri soci e docenti, originariamente postate su Facebook, che speriamo possano stimolare ulteriori riflessioni.
———
Giulia Addazi
Quasi nessun professore riesce ad arrivare fino a Caproni nel programma di quinto. Vero. Ma la poesia è semplice e con un messaggio immediato (al limite del banale), hanno detto in molti. Vero di nuovo.
Ma il punto è: cosa stiamo chiedendo ai nostri studenti? Perché se gli chiediamo solo di comprendere il senso di un testo e analizzarne la lettera secondo gli strumenti di analisi linguistica e retorica che per cinque anni ci siamo affannati a fornirgli, forse, non ci è ancora chiaro che l’analisi strutturalista è leggermente démodé e, soprattutto, che un testo non può essere descritto ignorando i rapporti che intrattiene con altri testi, o la tradizione, la poetica, il contesto storico, politico, sociale in cui un autore si muove.
Si insinua allora il dubbio che, dopo anni di teorie funzionali (cioè: facciamo scrivere e parlare i ragazzi delle cose che conoscono, che li appassionano o che – comunque – costituiscano riferimenti reali per loro), alla fine ci riduciamo sempre a premiare chi meglio ce la sa intortare. Li istighiamo a scrivere di ciò che non sanno – ma a farlo bene, con bei periodi lunghi e complessi (e una poesia come quella di Caproni non rende difficile il compito, in effetti: giù con banalità sull’amore per la natura – bleah!). Forse, la cattiva abitudine a premiare il Pierino del dottore di turno, abituato a esercitare la vuota magniloquenza, è un difetto che la scuola italiana non riesce, o non vuole, correggere.
A cinquant’anni dalla pubblicazione di “Lettera a una professoressa” e dalla morte di Don Lorenzo Milani (in un anno in cui – nel bene e nel male – del priore di Barbiana si è parlato tanto, anche dagli altri scranni del ministero), pare che la lezione non sia stata ancora recepita. Anzi, temo che da certi editorialisti borghesucci e radical chic possa venire un osanna generale al “grande Caproni, troppo poco studiato, per la verità”.
E allora vi ripropongo il celebre racconto delle carrozze ferroviarie e del tema di licenza media, da “Lettera a una professoressa”.
A giugno del terzo anno di Barbiana mi presentai alla licenza media come privatista. Il tema fu: «Parlano le carrozze ferroviarie». A Barbiana avevo imparato che le regole dello scrivere sono: Aver qualcosa di importante da dire e che sia utile a tutti o a molti. Sapere a chi si scrive. Raccogliere tutto quello che serve. Trovare una logica su cui ordinarlo. Eliminare ogni parola che non serve. Eliminare ogni parola che non usiamo parlando. Non porsi limiti di tempo. Così scrivo coi miei compagni questa lettera. Così spero che scriveranno i miei scolari quando sarò maestro. Ma davanti a quel tema che me ne facevo delle regole umili e sane dell’arte di tutti i tempi? Se volevo essere onesto dovevo lasciare la pagina in bianco. Oppure criticare il tema e chi me l’aveva dato.
———
Michelangelo Pecoraro
Caproni mi piace; non quanto Pascoli o Montale, per stare agli autori nel programma dell’ultimo anno, ma mi piace.
Non trovo disprezzabile il tema della poesia scelta per l’esame di maturità di quest’anno, cioè il rapporto tra la natura e l’uomo, tutt’altro: lo trovo adeguato al periodo storico e foriero di stimolanti riflessioni. Qualcuno lo definisce “banale”, ma ritengo che questo tipo di giudizi lasci sempre il tempo che trova: spesso ciò che viene etichettato come “banale” o “superficiale” è più interessante e meno opinabile di tanti pensieri “profondi” o “complessi” (categoria analitica, non ontologica, ormai applicata, a mo’ di giudizio definitivo, a qualsiasi cosa si ritenga degna della propria attenzione); se non la pensassi così, non apprezzerei a tal punto le poesie di Leopardi o le lettere morali di Seneca, autori tra i miei preferiti e spesso “banali”, ma di quella “banalità” che io preferisco chiamare “saggezza”.
Ma c’è un “ma” e non di poco conto.
Come in molti già hanno notato, la poesia scelta pone un problema di principio, cioè cosa viene richiesto ai ragazzi, quali abilità si tenta di sollecitare attraverso questa prova.
Caproni, ottimo poeta che non ha certo bisogno di apologie o apoteosi, non viene quasi mai fatto studiare dai docenti, nel corso dell’ultimo anno; al massimo, se ne fanno leggere una o due poesie durante il biennio, quando si studiano gli strumenti retorici dell’analisi poetica. Dunque, dopo anni passati a spiegare ai ragazzi (e ai genitori, nel corso dei colloqui) l’importanza dello studio e della conoscenza del contesto (storico, letterario e artistico in senso lato) per spiegare i prodotti dell’agire umano, gli si dà da scrivere riflessioni su un autore di cui si è detto poco o niente. Insomma, il timore è che il messaggio di fondo sia: “Vediamo come ve la cavate, perché nella vita vi capiterà spesso di dover discutere e argomentare su cose delle quali non saprete nulla”.