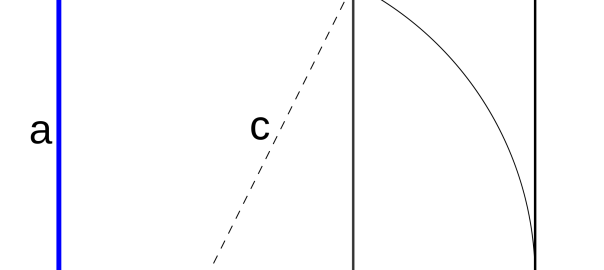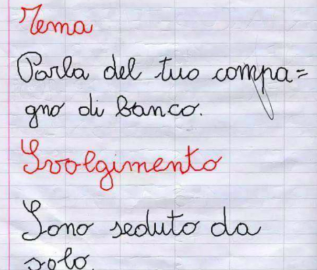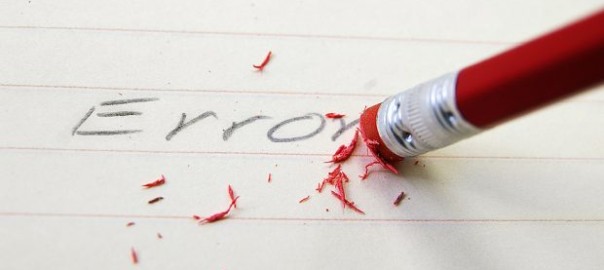Quest’anno gli studenti di quinto liceo scientifico saranno alle prese con una seconda prova mista di matematica e fisica. Si tratta di una novità sostanziosa rispetto agli anni passati, in cui era prevista una prova su un’unica materia – di fatto sempre matematica, in tempi recenti. Si possono scorgere le buone intenzioni del Ministero, che cerca di integrare in maniera armoniosa le due discipline. Personalmente non posso che approvare da questo punto di vista: troppo spesso infatti i due linguaggi risultano paradossalmente scollati, con sfasamenti nei programmi che non vanno di pari passo, nessi storici che non vengono mai evidenziati, e tante altre piccole contraddizioni.
Purtroppo la prova di maturità costituisce solo l’ultimo passo della formazione liceale dei ragazzi e, senza una seria presa di coscienza di tutti i professori e degli studenti stessi, la riflessione resterà circoscritta al “come prepararsi per la prova finale” e non potrà estendersi al “come chiarire e sviluppare il rapporto tra matematica e fisica“, un discorso molto ampio e potenzialmente fruttoso che dovrebbe abbracciare l’intero ciclo scolastico.
Quello che mi sento di consigliare a tutti è tranquillità e fiducia. Sfatiamo lo “spauracchio” del problema di fisica, generalmente considerato più enigmatico di un quesito della Sfinge – non solo dai ragazzi nel doverne trovare la soluzione, ma a volte, anche dai professori nel doverlo spiegare. Sostituirei l’idea di una “soluzione da trovare” con quella di una “situazione da capire“. In questo modo sarà possibile sfruttare appieno la preparazione matematica su studio di funzione, risoluzione di equazioni, calcolo di integrali e quant’altro. Basta fermarsi qualche minuto a considerare che “calcolare una quantità vicino a un certo punto” può essere fatto andandoci con un limite. Pensate che una formula fisica nient’altro è che un’equazione, simile alle centinaia che trovate sul testo di matematica! Solo che la “x” può essere una forza “F”, una carica “Q”, eccetera. Se volete sommare tanti minuscoli pezzettini, un integrale definito può aiutarvi nel compito. E così via…
Come esempio di collegamento tra i programmi di matematica e fisica, consiglio di esaminare il quesito 6 della simulazione ufficiale del 28 Febbraio, magari in classe e con l’aiuto del professore o della professoressa, in cui viene presentato un collegamento interessante tra leggi del moto (cinematica del punto) ed il teorema di Lagrange (calcolo differenziale).
Attenzione perché nella simulazione non mancano le pecche, anche gravi, come ad esempio nel primo esercizio in cui si dà, a mio avviso, una scorretta interpretazione fisica della funzione q(t) (in realtà poi evidenziato anche sul sito del MIUR). Insomma, sembra che i primi a doversi chiarire il rapporto tra matematica e fisica siano proprio i tecnici del Ministero!
———————————————————————————————————–
Laudes, in occasione della nuova maturità 2019, ha deciso di pubblicare a cadenza regolare una guida per l’esame, in cui verranno analizzate le prove svolte finora nelle simulazioni: seguiteci su Facebook e sul blog per ricevere aggiornamenti sui post di approfondimento che pubblicheremo in questi giorni.
Ma non solo: anche quest’anno abbiamo attivato corsi di preparazione alla maturità con i nostri migliori docenti. Quest’anno sarà ancora più importante arrivare pronti, rilassati e preparati. Per qualsiasi informazione sui corsi di preparazione alla nuova maturità potete cliccare qua.