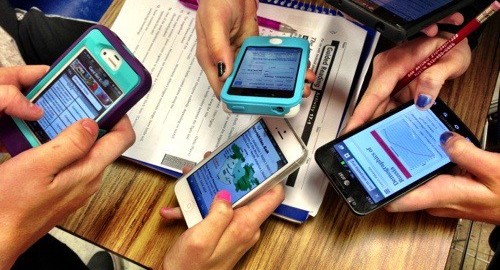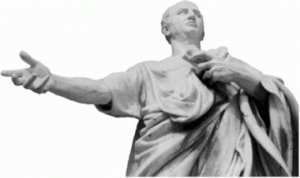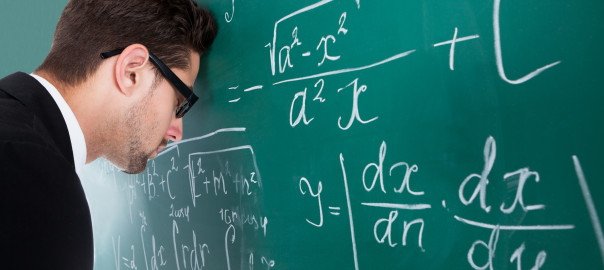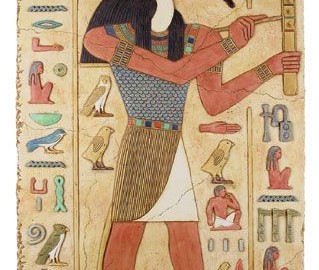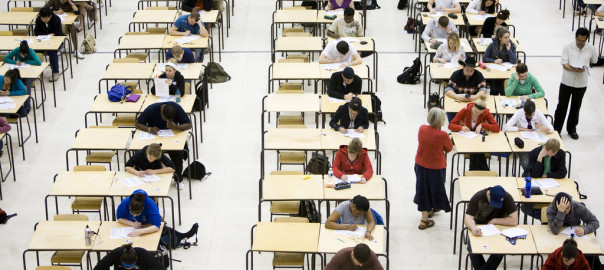I giovani non sanno scrivere, non leggono, non comprendono… Quanti editoriali sul tema, quante volte lo leggiamo sui social network, scritto da qualche nostro contatto, quante volte volte lo pensiamo noi insegnanti, scoraggiati da errori grossolani, da un’evidente fatica nell’espressione di un pensiero o nel mascherare l’assenza di un pensiero. È una reazione comune; l’importante è che rimanga confinata nella categoria “giudizi di pancia”, quelli che ti fanno esclamare “Eddai! Come si fa?”, quando correggi l’ennesimo riassunto in cui non è stato compreso il senso di un testo, anche banale. Ma appunto, l’insegnante deve andare oltre il giudizio di pancia, oltre il pessimistico O tempora o mores. Ce lo ricordava il professor Luca Serianni l’anno scorso, durante la sua lectio magistralis per l’ultimo anno di insegnamento, che “chi sceglie di fare l’insegnante non può permettersi il lusso di essere pessimista, perché ogni allievo è una risorsa preziosa”.
Come generalmente accade, nelle critiche generazionali che vengono rivolte ai giovani, la colpa è sempre di qualcosa che distrae dalle cose che contano, come la lettura: la musica pop, la televisione, i videogiochi e oggi, su tutto, gli smartphone. “Sempre attaccato a quel coso”, “Sempre a fare video/fare foto/chattare”; l’alternativa sarebbe leggere “un buon libro” (anche qua, ci sarebbe da discutere sui libri come entità che automaticamente elevano la mente, a prescindere dal loro contenuto).
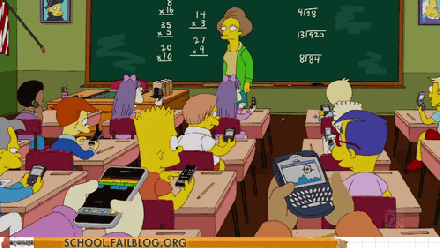
Ora, sicuramente rispetto ad altri momenti della seconda metà del ‘900 (non spingendoci oltre coi paragoni), il “libro”, inteso come oggetto di fruizione di contenuti (narrativi, informativi, argomentativi), è messo in minoranza da altri mezzi e formati, come serie tv, videogiochi e social network; tuttavia, non abbiamo grandi notizie su età dell’oro in cui la maggior parte dei giovani leggeva, anziché fare qualsiasi altra cosa considerata più divertente (leggere fumetti, guardare la tv, giocare o uscire con gli amici, ecc.). Leggere non è mai stata tra le attività preferite della maggior parte dei ragazzi.
È un’attività faticosa di per sé, che soprattutto nella giovinezza richiede impegno e motivazione, e non potranno mai bastare argomentazioni anche valide sulla superiorità del libro e del testo lungo né, a maggior ragione, obblighi (chiedetevi, voi lettori, se la vostra passione per la lettura derivi da una costrizione o da ragioni personali, spesso incomprensibili). A questo fattore, dobbiamo aggiungerne altri con cui gli insegnati di oggi devono per forza di cose confrontarsi: 1) i ragazzi d’oggi in realtà già leggono tantissimo, molto più delle precedenti generazioni: solo che non leggono i testi che intendiamo noi, ma messaggi su Whatsapp, didascalie di foto a Instagram, hashtag, meme, ovvero testi brevi, frammentari, con pochi legami logici espliciti; 2) sono abituati a una lettura pervasiva e non isolata da altre attività, non condotta in alcuni momenti specifici della giornata (mettersi a letto a leggere), al contrario leggono in contesti in cui la lettura si fa parallelamente ad altro (mentre si guarda la tv, mentre si sta con gli amici, mentre si sta a scuola o a lezione); 3) questa lettura di superficie si alterna velocemente, sullo stesso mezzo (principalmente lo smartphone), sulla stessa applicazione (social network), alla fruizione di contenuti formalmente diversi, come immagini, video, audio.
.png)
La lettura è quindi un’attività già conosciuta, padroneggiata, ma condotta con frame cognitivi che poi, per forza di cose, vengono estesi anche alla fruizione di testi di natura diversa (un manuale scolastico, un articolo di giornale, ecc.). Il risultato frustrante è che quei frame, di lettura veloce e a salti, non funzionano su testi lineari e complessi, che richiedono, al contrario, una lettura intensiva e focalizzata unicamente sul testo e sulla sua interpretazione. Non funzionano perché sono testi completamente diversi, che basano la loro struttura e il loro valore semantico sulle strutture tradizionali della lingua (lessico, sintassi e testualità) e molto meno sull’implicito, sulla dialogicità, sulle immagini e sull’insieme di conoscenze condivise, tipiche dei testi di cui normalmente i ragazzi hanno esperienza.
Questa totale diversità di approccio alla lettura e esperienza dei testi è all’origine di molte difficoltà didattiche odierne, a partire naturalmente dalla lettura di libri e dei manuali scolastici, considerati troppo difficili e quindi inutilizzabili, o ormai ridotti, per le dette difficoltà, a testi superficiali compensati da apparati paratestuali ipertrofici e banalizzanti, che forse aiutano lo studente a superare un’interrogazione e a rispettare i programmi ministeriali, ma di certo non lo aiutano a confrontarsi con tipi di testo diversi e con la lettura intensiva.
È dalla consapevolezza della diversità, radicale, tra il mondo scritto in cui sono cresciuti gli insegnanti e quello in cui stanno crescendo i discenti, che bisogna partire, per rendere efficace l’insegnamento: magari dedicando un po’ più di tempo alla lettura di testi non letterari, al confronto tra i tipi di testo ai quali loro sono abituati e quelli che conosciamo noi, al confronto tra i registri e le possibilità espressive dei registri. Siamo solo all’inizio, siamo la prima generazione di insegnanti a confrontarsi con questi aspetti, e forse saremo l’unica a farlo in un contesto così problematico: ma proprio questo ci obbliga a uno sforzo di comprensione che vada oltre la demonizzazione dei giovani e dell’evoluzione tecnologica.